 | ||
|
Numero 6 Feed RSS 
Archivio |
stampa questa pagina [versione printer friendly]
La rivoluzione spiegata alle commesse, Roberto Carvelli, Coniglio Editore Romanzo picaresco, ricco di personaggi strambi e teneri, La rivoluzione spiegata alle commesse fissa lo sguardo sulle storie di uomini e donne (ci affacciamo su queste pagine come se fossero finestre aperte sul quotidiano) che lottano per sopravvivere, per arrivare alla fine del mese, per trovare o tenersi un lavoro decente, una casa di due camere, un compagno o una compagna a cui dire buonanotte alla fine della giornata. Distrazioni, poche. Per chi vive a Torreverde, immaginaria borgata romana, simile ai quartieri periferici di tutte le città, il tempo passa lento e ci si ritrova al Bar Libano a chiacchierare di sport e di donne. Oppure di rivoluzione. Di strategie per il cambiamento. Ed è così che Bebo, commesso in una merceria, sensibile al fascino femminile ed ex studente ribelle, assieme ai suoi amici dai nomi improbabili (Stinchi Pirinchi, nonno Adinolfi, Zagalot, Nena…) decide, fomentato da impegnative letture di sinistra e dalle conversazioni filosofiche con il “maestro”, Doctor You, intellettuale introverso e romantico, di intraprendere una sgangherata marcia rivoluzionaria. Disorganizzazione e idee poco chiare, spirito di concretezza del tutto assente condurranno la rivoluzione al suo implodere. Saranno in grado questi sfortunati eroi di fare i conti con il fallimento?
Il campionario di scritte sui muri, di modi di dire e di tipiche storielle frutto di fantasia, come quella che vuole i water di Torreverde intasati da coccodrilli o gli ufo visti atterrare sui campi di grano, è la scelta letteraria che soggiace alla composizione del libro per raccontare la periferia, e anche per questo il libro si rivela inventivo e brillante. Questo romanzo getta uno sguardo critico – e, per fortuna, ancora capace di ironia – sulla nostra società che più che offrire, riconoscere, tutelare sembra togliere, negare, offendere; uno sguardo allo stesso tempo distante e partecipe, che si posa sui sogni infranti delle famiglie, delle giovani coppie o di chi è rimasto solo, e ci dice che il precariato non è solo il tratto che rende tipico l’ambito occupazionale, oggi, ma finisce con l’essere segno distintivo delle identità e della contemporaneità; il “nomadismo sentimentale” di Bebo, ad esempio, non è un malinconico risvolto di questa precarietà che tocca persino la vita affettiva? Se, come recita la bandella del libro, che delinea la tendenza della collana, qualcosa dovete pur mettere nelle vostre nuove librerie Ikea, allora metteteci anche questo libro. Ma prima, ovviamente, leggetelo! Leggerlo è un atto dovuto, ché di commesse è pieno il mondo e anche dei loro sogni segreti di rivolta; ecco perché queste pagine meritano attenzione. Il sogno di libertà e di felicità dei numerosi personaggi che affollano il romanzo resta periferico, marginale, non riesce a diventare azione coerente, e manca l’obiettivo. In realtà, però, queste piccole formiche che hanno rotto le linee, e che disordinatamente annaspano, sembrano comunque voler dire che non tutte le rivoluzioni sono utopie o si svuotano di senso lungo la strada o hanno bisogno di gesti eclatanti. Molte si fanno ogni giorno, giorno dopo giorno. Nei posti di lavoro, dentro alle case, negli ospedali, nelle scuole. Se ci chiedessimo: “cosa resta, allora, dopo la rivoluzione?”, risponderemmo che, dopo la rivoluzione, ciò che resta è sempre e comunque la vita. A dispetto del titolo, questo libro c’entra poco sia con la rivoluzione che con le commesse. O meglio, pur raccontandoci di questo, a ben vedere, è della periferia che parla, della periferia come luogo non luogo, come luogo delle possibilità latenti o represse o semplicemente addomesticate. Periferia inesistente sulle cartine, quella di Torreverde (nome inventato eppure evocativo, che ricorda i nomi di altre borgate – vere – romane), e allo stesso tempo vivida, realistica, possibile. E qui si fanno strada altre riflessioni: sulla vivibilità degli spazi urbani, sul ripensamento dei confini, fisici e metafisici, tanto per cominciare. (Daniela D’Angelo)
«Se voi siete il diavolo, allora non sono io a raccontare questa storia. È non-io, Out-in-the-Shed, Fuori-nella-Baracca. Questo è il nome che mi aveva dato lei senza neanche saperlo. […] Credevo di chiamarmi anche Ehi-tu e Vieni-un-po’-qui-ragazzino. Più o meno per i primi dieci anni di vita pensavo di essere quello che dicevano queste parole “tybo”. “Tybo” significa “uomo bianco” nella mia lingua. E la mia lingua è poche parole che ricordo ancora.»
Ma il nome con cui si cresce non è per forza il nome con cui si è nati, e prima o poi i conti devono tornare. Gli Stati Uniti di fine Ottocento sono quelli dei cow-boys e degli indiani persi nelle riserve e nell’alcool, dei mormoni che hanno deciso che l’unica giustizia possibile è la loro, dei bordelli dove Ida Richilieu serve bottiglie e bottiglie di whisky, dove Alma Hatch riceve i suoi clienti nella stanza numero 11, dove un ragazzino mezzosangue viene violentato da Billy Blizzard e, dopo aver sepolto sua madre su Non-una-vera-montagna, trova il suo rifugio in una baracca e, avvolto in un boa di piume, regala whisky e piacere agli uomini di Excellent. Questa è la sua vita tybo, ma non basta. Un giorno Shed chiede ai suoi occhi, alle sue gambe e al suo cuore di aiutarlo a scoprire il significato del nome Bannock, o forse Soshone, che gli aveva dato sua madre: Duivichi-un-Dua. Inizia così il viaggio in cui scoprirà la sua gente, troverà il significato del suo nome, ma sopratutto incontrerà, amerà, riderà e piangerà per l’uomo che si innamorò della luna. Dopo aver scoperto la sua vera natura potrà tornare a Excellent: lui, Ida, Alma e Dellwood saranno una famiglia: potranno amarsi, bere, fumare e ridere, dovranno difendersi da chi ha già deciso della loro anima, conoscere e affrontare la verità, dovranno scoprire se stanno giocando una partita in cui il mazzo di carte è truccato e se poi è tanto importante vincere proprio quella mano. Questo è il romanzo che ha reso famoso Spanbauer negli Stati Uniti, soprattutto per la sua capacità minimalista di costruire azzardati percorsi spazio-temporali, in cui svolgere vicende dai contorni spregiudicati. In questo libro si scopre la sua abilità nel creare una storia con tecnica e ricchezza, sviluppando, per esempio, materiale “pericoloso” come l’amore incestuoso tra padre e figlio, senza perdersi, ma con la calma e la serenità di chi ha in mano l’unica chiave possibile e sa bene quante volte deve girare perché la storia funzioni. La sua scrittura è ferma, definita e sicura e proprio per questo prepara con cura il sentiero per il lettore, lo aspetta senza forzarlo ma sapendo bene che arriverà dove lui vuole. È con questi presupposti che Spanbauer ha fondato una delle più importanti scuole di scrittura creativa degli Stati Uniti, la “Dangerous Writing”, dove si è formato uno scrittore “pericoloso” come Chuck Palaniuk. Il romanzo di Shed è quindi una storia fatta di scatole chiuse che lui cerca di aprire lentamente, di mettere in cerchio rivolte verso il cielo per scrutarle e scoprire che le cose non stavano come avevo sempre creduto io, e cioè che io non facevo quel che pensavo di fare e che, alla fin fine, non ero assolutamente quello che pensavo di essere. (Silvana Cannas) La vita in comune, Letizia Muratori, Einaudi Stile Libero  La vita in comune è un romanzo che non si dimentica. Sul serio. Racconta le tensione, i disfacimenti di una famiglia borghese attraverso un coro di voci narranti che, come negli antichi cori greci, evocano il fato disgregatore in cui la storia si compie. Ma ci sono anche speranza, cambiamento. Tutto scorre però attraverso il dolore. Il libro traccia un filo rosso che lega l'oggi agli anni Settanta, l'Italia all'Eritrea, passa attraverso gli snodi del lavoro, della guerriglia, dei problemi di fame e di sete. Tre protagonisti tessono le loro storie in questo unico canto che ha come denominatore comune la percezione del pericolo, quella che lega fra loro uomini, animali e piante. Così come l'arrivo di un temporale carica l'aria e viene fiutato dalle bestie inquiete, così "la vita in comune" somma ogni creatura nell'inquietudine del pericolo, quel pericolo che si fa vita. Solitudine e amore sono gli estremi di questo percorso (percorso che viene ben narrato nel libro proprio attraverso l'intreccio di queste storie, che si intercettano e a vicenda si compiono). La prosa di Letizia Muratori a tratti procede attraverso suggestioni e umori "umidi", altre volte si fa secca, spietata, come il sole cocente di un mezzogiorno di agosto. Ancora una volta Einaudi Stile Libero fa propria la scelta di una scrittura moderna, graffiante, che si scosta felicemente dagli stereotipi narrativi che sembrano affollare le nostre librerie. Ben venga. (Alina Padawan) Wei Wei, La ragazza che leggeva il francese, e/o  "I pochi brandelli di frase che all'epoca aveva cercato di farci entrare in testa erano bastati a farmi intravedere l'abisso tanto largo quanto profondo che separa una lingua alfabetica, formulata per l'orecchio, e la mia [il cinese] lingua, monisillabica e ideografica, elaborata per la vista.." [...] "Dopo la fonetica, la grammatica francese. Ma...come? Una tazza? Un bicchiere? Un piatto? Una scodella? La tavola è femminile e il letto maschile? Quando si tratta di animali e di esseri umani, posso capire. Un gatto non è una gatta, un ragazzo non è una ragazza, è evidente. Ma gli oggetti, le cose senza vita? È logico suddividerle in maschile e femminile? [...] Nella mia lingua, il cinese, l'aggettivo non varia mai, nemmeno se il sostantivo al quale è unito indica una sola donna o un miliardo di uomini!" Wei Wei è una ragazza cinese che sin da bambina sogna di studiare medicina, verrà, invece, portata a diventare un'interprete, e quindi a studiare il francese, Ma è attraverso i romanzi francesi un nuovo mondo si presenta alla nostra protagonista. Leggendo questo romanzo sembra di sostare su di una soglia. Da una parte
da rileggere Diario di un gatto con gli stivali, Roberto Vecchioni, Einaudi
E vissero felici e contenti…
E se invece non fosse così? Ma siamo proprio sicuri che i finali delle fiabe siano necessariamente quelli che ci aspettiamo? A questi interrogativi cerca di dare una risposta il poliedrico Roberto Vecchioni, che nel suo libro “Diario di un gatto con gli stivali” si cimenta in una rivisitazione, in chiave moderna, delle fiabe più conosciute. La sua si presenta come una decostruzione della tradizionale struttura narrativa, in cui l’inserimento del senso del dubbio, applicato alle psicologie dei protagonisti delle storie, fa si che le maschere dei diversi personaggi diventino intercambiabili. In generale, le fiabe e le favole si dipanano secondo uno schema ben definito, che vuole trasmettere in chi legge un senso di sicurezza, infondere un messaggio positivo e, in un qualche modo, consolatorio. Il denominatore comune che unisce la totalità delle favole è infatti rappresentato da una morale di giustizia in cui, immancabilmente, il bene trionfa sul male: tutti possono vivere felici e contenti, anche il povero può fare fortuna e ogni personaggio ha di fronte a sé delle prove, che una volta superate gli permetteranno di ottenere una vita migliore. Del resto, l’articolazione della fiaba era stata teorizzata, agli inizi del secolo scorso, dallo studioso russo Vladimir Propp, il quale aveva individuato nelle cosiddette “funzioni” gli elementi costanti che si presentano nel testo fiabesco secondo un determinato ordine. Seguendo il sistema di Propp, si nota come i personaggi delle fiabe sono innumerevoli e diversi, ma le azioni che essi compiono rientrano in una gamma ben definita e si ripetono spesso. L’eroe protagonista si trova a dover affrontare mille peripezie, a dover lottare contro forze avverse e, soltanto alla fine, ottiene la giusta ricompensa per i suoi sforzi. Il lieto fine è assicurato e, a seconda dei casi, può essere rappresentato dalla conquista dell’amata, dallo scioglimento di un incantesimo o più semplicemente dalla disfatta del personaggio negativo. Questo ordine precostituito viene totalmente stravolto nel libro di Vecchioni, dove buoni e cattivi si scambiano i ruoli e niente è come sembra. L’ingenua Cappuccetto rosso lascia il passo a una presuntuosa e spregiudicata ragazza, Pollicino soffre di crisi d’identità così forti da pensare al suicidio, il gatto con gli stivali tiene un diario in cui annota tutti i suoi progetti malvagi e il principe azzurro di Biancaneve assomiglia sempre più a un uomo annoiato e non più innamorato della propria compagna. Attraverso il gusto del contrario l’autore fornisce al lettore una chiave insolita e dissacrante, ipotizzando quindi interpretazioni diverse da quelle tradizionali. E’ come se gli ingredienti delle fiabe venissero rimescolati e andassero a intaccare l’aspettativa ultima, ovvero una rassicurante conclusione. Le vie percorribili non sono dunque date aprioristicamente: si apre un nuovo ventaglio di possibilità e di finali imprevedibili come nella vita. Nel “Diario di un gatto con gli stivali” Roberto Vecchioni applica al genere favolistico il collegamento tra mondo reale e mondo fantastico, una delle costanti della sua produzione di cantautore. La classica cristallizzazione di situazioni viene trasfigurata in un prisma sfaccettato, per questo più reale e più umano, dove davvero niente è come appare. (Raffaella Sirena)
Le intermittenze della morte, José Saramago, Einaudi
(Barbara Ronca)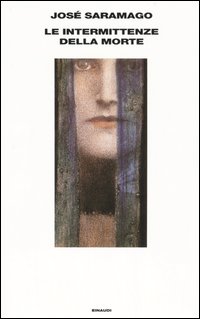 Come Saramago ha indicato in molti commenti ai propri scritti, l’adesione del lettore all’ “assurdo” dei suoi romanzi implica l’allineamento a una schiacciante consequenzialità che, anche nel caso delle Intermittenze della morte, apre le prospettive dell’incontro letterario a una logica del possibile. Il tono sarcastico definisce gli strani accadimenti che travolgono un imprecisato Paese -niente ha nome nel mondo di Saramago-, vittima di una morte volubile che, prima, infligge l’eternità con uno sciopero di sette mesi e, in seconda battuta, riprende implacabile il suo esercizio di definizione della vita, decimando la popolazione e dandone preavviso epistolare. Ma qualcosa non funziona e una missiva inviata a un violoncellista che ‘deve morire’ torna per tre volte al mittente. La morte, allora, si fa bella, e prende le sembianze di una donna per spiare meglio la sua vittima ostinata, trasformando quello che credeva un banale intoppo in una variazione sul tema, un’avventura nuova, per lei che, come mai prima, si scopre stordita dal fascino imprevisto di sensazioni vitali e sconosciute. L’umanità, travolta dai giochi della morte, è descritta nella sua essenza sociale. Meglio un’esistenza senza fine o l’anteprima del trapasso? La seduzione dell’eternità è inizialmente molto forte, ma le istituzioni vanno in tilt e l’intero sistema rischia di essere ribaltato sotto il punto di vista politico, economico, ideologico: il potere non può gestire la vita eterna, né l’immortalità concede speranza di resurrezione ai credenti. Fede e ragione vacillano. Destabilizzata nei cardini della sopravvivenza, l’umanità di Saramago sembra incartata nelle proprie meccaniche, incapace di resistere alla follia, alla disperazione e alla rabbia. Uomini come tanti polli impazziti nell’aia, come un gregge di pecore senza cane da pastore. Come succede anche oltre le pagine di un libro. Ed è per questo che il lettore non sente la mancanza del nome di questo paese emblematico, né di quello dei protagonisti di una storia che esprime, attraverso l’assurdo, il loop che mai risparmia le miserie umane. Eppure, anche la morte diventa vittima inattesa di uno smarrimento che cambia le carte in tavola e rovescia gli abusi di potere, portando la vicenda in un altrove che intuiremo a libro chiuso. L’incontro con la musica, per la tragica signora, è il colpo al cuore che regala la coscienza di una umanità resa meno banale dalla sintesi balsamica dell’arte: «quello che impressionava la morte, era il fatto che le era parso di sentire in quei cinquantotto secondi di musica una trasposizione ritmica e melodica di una qualsivoglia vita umana, normale o straordinaria, per la sua tragica brevità, per la sua intensità disperata, e anche per via di quell’accordo finale che era come un punto di sospensione lasciato nell’aria, nel vago, come se, irrimediabilmente, fosse rimasto ancora qualcosa da dire». (Seralisa Carbone) Le Catilinarie, Amélie Nothomb, Voland 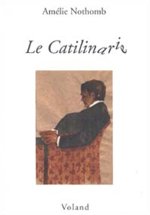 ‘Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?’ Marco Tullio Cicerone, I Catilinaria Deve aver avuto in mente proprio questa domanda Amélie Nothomb, scrittrice cult belga ma francese d’adozione, quando ha pensato alla trama del suo romanzo Le Catilinarie, che nel titolo esplicitamente richiama le celebri orazioni ciceroniane. E deve averla ritenuta uno spunto narrativo più che una domanda retorica, visto che ha provato, nelle poco più di cento pagine del suo libro, a seguire il filo rosso di una delle risposte possibili. Il nucleo incandescente de Le Catilinarie è infatti Palamède Bernardin (rompiscatole ‘archetipico’, ‘mitologico’), colui che abusa dell’altrui pazienza fino alla fine, fino alle estreme conseguenze del suo sopruso. Perché questo fa, spesso, Amélie: scava nell’irrazionale mistero dell’umano, scova una scintilla, un’immagine, un segno, e lo segue implacabile fino alle sue (in)naturali evoluzioni. Storia sognante e surreale, Le Catilinarie si apre presentandoci i suoi protagonisti, Juliette ed Émile Hazel, coniugi sessantenni uniti fin dall’infanzia da un amore tenero e complice. Spinti da un ‘bisogno forsennato’, più ancora che un desiderio, di ‘lasciare quella perdita di tempo che è il mondo’, comprano una casa in campagna, ‘graziosa, invisibile, scalata da un glicine’. Forti di un amore che basta a se stesso, i due decidono di abbandonarsi lì ad un sereno isolamento, per tutto il tempo che resta loro da vivere. Ma qualcosa si insinua nella vita dei due coniugi, trascinandoli pian piano lontani dal loro idillio: il vicino, dottor Palamède Bernardin, che un giorno bussa alla loro porta, apparentemente per far la loro conoscenza. Accomodatosi su quella che diverrà la ‘sua’ poltrona, evidentemente contrariato per la presenza dei suoi ospiti, annoiato dai loro tentativi di conversazione, risponde laconicamente a monosillabi alle loro domande: eppure (è qui che Amélie introduce la deviazione dalla norma, l’insania che squarcia la banalità del quotidiano) non se ne va. Per due ore lunghe e penose, Émile e Juliette sono obbligati a cercare di intrattenere un uomo sgradevole e grottescamente obeso, il cui ostinato rifiuto di stabilire un contatto fa da assurdo contraltare alla sua ostinazione a voler rimanere nel loro salotto. Da quel giorno, ogni pomeriggio, con inesorabile puntualità, Palamède Bernardin bussa alla porta dei coniugi Hazel; le due interminabili ore del primo incontro si trasformano in un’inquietante routine, i cui risvolti ossessivi si fanno sempre più evidenti. L’unione indissolubile di Émile e Juliette si ribella al grottesco che Bernardine incarna alla perfezione; ma la guerra che li vede coinvolti li vuole perdenti. Proprio di guerra, ci dice la Nothomb, si tratta infatti (non è un caso che Bernardin esca spesso ‘vincitore’ dai suoi pomeriggi dai vicini); è una lotta animale, un ‘assedio (…) infernale e senza uscita’ in cui i monologhi di Émile e Juliette, che si oppongono coraggiosamente al silenzio di Bernardin, sono veri e propri fatti d’armi, tentativi di resistenza. Ma, se possibile, tutto questo non è ancora il peggio che Bernardin ha da offrire: il peggio è sua moglie, grassa, abnorme, deficiente; una ‘cisti’, come la definisce sarcasticamente Émile, voce narrante del testo; una ‘tumefazione’, un ‘mammifero’ che ingurgita il cibo con disgustoso godimento, una creatura primitiva e ributtante che ben si colloca nella galleria di personaggi eccessivi e paradossali che contrassegna le opere della Nothomb. Eppure l’autrice, il cui sguardo si posa gentile e spietato ad un tempo su queste vite mostruose, sembra strizzarci l’occhio; e dirci che lei preferisce la debordante primordialità di Bernadette Bernardin alla torva assenza di sentimenti del marito. Perché ‘la voluttà eleva’, come ci ricorda Émile, ‘qualunque ne sia la causa’; e l’incapacità di Bernardin di provare piacere ne fa un subumano, più di quanto possano l’orrendo corpo e la mente tarata di sua moglie. In un romanzo che si snoda fluido e piacevole fino al sorprendente epilogo dai risvolti macabri, spiccano le capacità linguistiche e stilistiche dell’autrice, che tutto usa con misura perfetta: la sua solida cultura, l’ironia intelligente, un certo gusto quasi punk per il raccapricciante. La totale assenza di barocchismi, di ridondanze, di eccessi, modella la materia rovente della trama in un testo di grande pulizia formale, ma anche di straordinaria intensità. Il linguaggio di Amélie si modula docile attorno agli eventi narrati; il suo rigore, la sua purezza, la tenue poesia di alcuni momenti (‘… era un inizio d’aprile come lo descrivono nei libri di scuola, con fiori leggeri come le eroine di Maeterlinck…’) sembrano richiamare le origini giapponesi della scrittrice, nata a Kobe e a lungo vissuta nel paese del sol levante. Di lei, leggenda vivente, si raccontano storie di eccessi ed inquietudini; si dice che abbia scritto più libri di quanti anni abbia – 40 -, ma che li pubblichi centellinandoli, uno all’anno, per la sua piccola casa editrice francese Albin Michel, a cui è sempre fedele (come in Italia è fedele alla Voland). Forse proprio per la sua vita travagliata e fuori dall’ordinario Amélie riesce così bene a cogliere il fascino dell’umano - come quello del disumano. E riesce anche, come fa magistralmente con Le Catilinarie, ad immergersi lieve nell’assurdo del mondo, riemergendone con in mano una piccola perla letteraria. |
|
 | ||




