 | ||
|
Numero 18 Feed RSS 
Archivio |
stampa questa pagina [versione printer friendly]
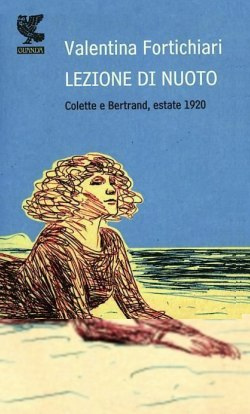 “Ho trovato nel Salento un posto da cui guardare il mare e desiderare solo di nuotare e di scrivere.” “Ho trovato nel Salento un posto da cui guardare il mare e desiderare solo di nuotare e di scrivere.” Così mi racconta Valentina Fortichiari, autrice di Lezione di nuoto edito da Guanda lo scorso anno, e a me fa venire in mente la Bretagna, luogo in cui è ambientato, appunto, questo libro: non certo per la somiglianza fisica dei luoghi (non potrebbe forse esserci lontananza più grande tra il freddo nord della Francia e la terra rovente del nostro sud Italia) quanto, piuttosto, per un amore, comune all’autrice e a Colette, che di questo racconto è protagonista indiscussa, quello per l’acqua. La Fortichiari, nuotatrice agonistica ai tempi, e Colette, esperta conoscitrice del potere liberatorio di questo elemento, che decide di invitare il figlio di primo letto di suo marito a trascorrere una vacanza con lei e con il suo gruppo di amici letterati proprio nella sua casa sulla costa bretone. Il romanzo (è il 1920 e siamo nella villa di Rozven in Bretagna, lasciata a Colette dall'amica Missy) apre uno squarcio sull’inizio di quello che diventerà poi un lungo rapporto di passione e d’amore: Colette insegna a Bertrand a nuotare e, sciogliendo con sapiente maestria quel nodo di insicurezza e di timorosa reverenza che tiene avvinto il giovane cuore di lui, lo lega in un coinvolgimento che parte dal contatto dei corpi nell’acqua e arriva alla mente nell’innamoramento per la parola scritta. In quella mitica vacanza, sotto il riverbero del sole e circonfusi dagli aromi della cucina di Colette, anche la compagnia di intellettuali e artisti contribuisce a disvelare sentimenti estremi, come quello della piccola figlia di Colette, sempre in cerca di attenzione da una mamma che sembra non avere abbastanza energie anche per lei, come quello della fedele segretaria e amica di Colette, consumata in un amore senza speranza, e infine come quello dell’autrice per lo spazio acquatico, concentrata, allo stesso modo, nel movimento fluido del nuotare e dello scrivere. Non tragga in inganno la raffinatezza nell’uso della lingua: la Fortichiari ci mette a parte di passioni forti e vitali, senza riserve, seppure con grande eleganza. Il libro si legge d’un fiato, alla riscoperta di un personaggio oggi un po’ trascurato come è quello di Colette, il cui coraggio e la cui forza meritano invece la giusta considerazione, e ci chiama al diritto di amare e di volere tutto. Salvo poi pagarne le conseguenze. Raffaella Musicò Non saremo confusi per sempre, Marco Mancassola, Einaudi  Non saremo confusi per sempre di Marco Mancassola, già autore de “La vita erotica dei superuomini”,affronta, da vicino, il tema della realtà nella sua dimensione tragica e crudele, quella rappresentata da alcuni terribili fatti di cronaca che nell'ultimo decennio hanno scosso l'opinione pubblica e l'animo di chi si è trovato davanti alla loro rappresentazione. Non saremo confusi per sempre di Marco Mancassola, già autore de “La vita erotica dei superuomini”,affronta, da vicino, il tema della realtà nella sua dimensione tragica e crudele, quella rappresentata da alcuni terribili fatti di cronaca che nell'ultimo decennio hanno scosso l'opinione pubblica e l'animo di chi si è trovato davanti alla loro rappresentazione. Per ogni fatto di cronaca l'Autore utilizza un titolo che richiama il mondo delle fiabe: Eluana Englaro, per esempio è una “Bella addormentata” un espediente che permette al lettore di avvicinarsi ai fatti narrati come se si trattasse di una finzione, di un racconto inventato. Si potrebbe quasi pensare che ciò che è reale viene presentato nella sua dimensione teatrale e mediata. Ed è proprio di vita come “rappresentazione” che parla l'agevole opera di Mancassola: ogni fatto di cronaca, dalle vicende degli Englaro, fino al rapimento della incolpevole vittima della mafia, Giuseppe di Matteo sciolto nell'acido, viene letto con due chiavi di lettura. La prima è quella dell'occhio lucido del narratore che si materializza sulla scena di ogni fatto raccontandone puntualmente lo svolgimento, l'altra è una originale reinterpretazione sognante, a volte onirica e fantasiosa del reale, che si affida alla voce di quanti si aggirano attorno a quelle vicende, coloro che stanno dietro le quinte della rappresentazione mediatica della cronaca e vivono il loro dolore confondendolo con quello rappresentato sulla “scena”. Non è un caso che il riferimento al teatro è già forte nel primo racconto dedicato alla morte di Dirk Hammer, per mano del principe Savoia, che viene effettivamente “messa in scena” da una compagnia teatrale il cui regista visionario decide di cambiare il finale della vicenda permettendo al giovane di non morire ma di resuscitare e restare libero dal peso della morte che invece lo colse, tragicamente, condannando all'infelicità la propria famiglia. L'illusione di reinterpretare la realtà portandola in scena sotto una luce diversa anima non solo questo racconto ma tutto il libro, ne è il filo conduttore. Allora l'Autore conduce per mano il lettore proprio dietro le quinte della realtà, con una prosa schietta e prova di fronzoli, inducendo un'importante domanda: possiamo restare confusi per sempre sul confine fra realtà rappresentata e la sua sublimazione nella fantasia, oppure possiamo accettare la vita nella sua realtà più cruda e dolorosa e lasciarci andare ad essa, affrontarla nella sua dimensione adulta, senza “sparire davanti a se stessi” come fanno “tante persone, anche le più dotate... trascinati dalla deriva incontrollabile che spinge certi esseri umani...a sparire davanti a se stessi”. Ecco quindi che nell'opera di Mancassola vengono a crearsi due piani di illusioni: da un lato quello realizzato dai mass media, la cui presenza sulla scena dei fatti di cronaca è spesso talmente straniante da esasperare la reale percezione delle cose, dall'altro l'artifizio dell'autore che trasfigura la vicenda dandogli un lieto fine irreale e a tratti consolante. L'esempio calzante è quello fornito nella storia di Alfredino, il bimbo finito nel pozzo artesiano che tenne incollati al teleschermo tutti gli italiani. La ricostruzione della realtà attraverso il racconto di cronaca è dura e spietata, a tratti crudele nei dettagli dei tentativi di salvare il piccolo, nell'insistenza dei media nell'illuminare il pozzo dove il bambino stava morendo al buio. L'altro piano illusorio è quello operato da Mancassola che, interviene in funzione consolatoria nel momento più tragico, e trasfigura Alfredino facendogli fare un viaggio onirico ed immaginario al Centro della Terra, per sparire per sempre, senza morire. Nella storia di Giuseppe di Matteo, il ragazzo sciolto nell'acido per regolare un conto di mafia, la trasfigurazione del personaggio avviene in un fumetto realizzato da una compagna di banco, cresciuta nel suo ricordo e così reso immortale. Mentre nella vicenda di Federico Aldrovandi, il giovane pestato e ucciso dalla Polizia ferrarese, si ricorre alla sua trasformazione del protagonista in spettro. Proprio qui si affronta il nodo dell'illusorietà della vita. Il giovane assiste al suo funerale, cerca di avvicinarsi alla sua famiglia, nella lotta per il riconoscimento dell'ingiustizia subita. Alla fine, dietro consiglio di un altro fantasma, il giovane spettro finisce nella casa del Grande Fratello insieme al suo presunto persecutore, ed insieme ad altri ragazzi che come lui, sono morti di morte violenta senza “trapassare”. Nella casa del Grande Fratello, metafora forse spiazzante ed eppure perfetta della dicotomia fra realtà inquadrata dalle telecamere e realtà vissuta oltre quelle, si consuma l'ultima illusione, quella di poter vivere per sempre. Il giovane riconoscerà la pace eterna come inevitabile e saluterà per sempre attraverso le telecamere, sua madre, insieme a tutti gli altri fantasmi presenti. Tutti i racconti di Mancassola tendono, in ultima analisi, a fomentare l'illusione di poter creare una realtà diversa da quella presentataci dalla televisione, per sostituirla con una visione intimista del fatto di cronaca nella sua tragicità. Quel che si teme, leggendo le pagine di “Non saremo confusi per sempre” è però proprio lo smarrimento davanti al reale. Seguendo l'approccio positivo che sembra emergere nelle pieghe e nelle piaghe della vita, l'Autore pare intanto rassicurarci dicendo, “no, non saremo confusi per sempre”, troveremo il modo di superare quell'incontrovertibile bisogno dei media e di noi stessi di enfatizzare la realtà fino a trasformarla in un sogno. Troveremo la strada ed il coraggio di non essere per sempre dei fantasmi che si aggirano nella vita, come quello di Federico Aldrovandi, qui trasfigurato in uno spettro in cerca della pace eterna che appare chiara, solo quando viene riconosciuta nel suo essere “dolorosa”. Eppure il conforto nell'illusione di un lieto fine o di una diversa interpretazione del reale è spesso pericoloso e assume una intensità contraria e superiore alla cruda realtà, al punto di far oscillare il lettore per la prima. Ecco quindi che preferiremmo credere che il bambino nel pozzo artesiano di Vermicino si trasformasse realmente in un capitano coraggioso in viaggio verso il centro della terra, piuttosto che accettare la tragica morte accidentale che lo lega al giovane vittima Dirk Hammer, morto per mano di Vittorio Emanuele di Savoia, ed eppure resuscitato dalla penna di Mancassola per poter essere libero e vivo, lontano per sempre da noi e dalla nostra realtà, come lo si può essere solo nella fantasia. Antonio Maz Un pirata piccolo piccolo di Amara Lakhous, edizioni e/o 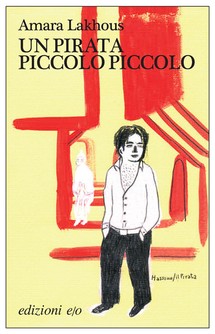 Dopo i successi di Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio e Divorzio all’islamica a viale Marconi, lo scrittore algerino Amara Lakhous torna in libreria con un nuovo romanzo, Un pirata piccolo piccolo. Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1999, ma purtroppo mai distribuito, il libro viene ora riproposto dalle Edizioni e/o, in un momento sicuramente appropriato. La situazione dei migranti in Italia, tema dei due precedenti romanzi, lascia il posto alla lotta per il pane e la libertà nell’Algeria dei primi anni Novanta, sprofondata in una grave crisi economica, politica e di valori. Lakhous affronta con ironia e schiettezza il disagio di una generazione che già allora chiedeva una trasformazione sociale, anticipando le rivendicazioni della Primavera araba, e ci dà delle chiavi di lettura delle attuali rivolte forse più chiare dei tanti saggi che ci si è affrettati a scrivere negli ultimi mesi. Hassinu, il personaggio centrale del romanzo, è un semplice impiegato delle Poste e vive da solo in un piccolo appartamento ad Algeri. Sta per compiere 40 anni, è scapolo e tira a campare con lo stretto necessario. Proprio il tipo di uomo che la società arabo-musulmana non ammette. Ma Hassinu non maledice la sua situazione. Non vuole una moglie e frequenta serenamente delle prostitute, anche se non riesce a scollarsi il ricordo di un vecchio amore. Svolge il suo lavoro onestamente, senza usufruire di appoggi o raccomandazioni. Crede in dio, prega e si reca alla moschea, ma cede alle tentazioni terrene e vuole vivere senza rimorsi la propria individualità, allontanandosi dagli aspetti più severi dell’Islam. Nel racconto lo seguiamo nelle sue azioni quotidiane: il lavoro, la pratica religiosa, gli incontri, le piccole commissioni, la vita sessuale. La storia si svolge su tre giorni, quelli precedenti al suo compleanno. È nato il 29 febbraio, e sta per passare con un brusco salto dai 36 ai 40 anni. Il risveglio improvviso nell’età della maturità, quella in cui Maometto riceve la rivelazione divina, lo sconvolge fin quasi al tormento, ma al tempo stesso saprà rafforzare in lui il sentimento di resistenza contro tutto e tutti. Il susseguirsi delle scene è scandito dal ritmo frenetico dei suoi pensieri, un monologo interiore fitto e dallo stile telegrafico nel quale Hassinu si abbandona alla più aspra polemica. I toni sono arrabbiati ma molto ironici. Se la prende con la società, la famiglia, i poteri pubblici ed economici. Con il suo discorso dà voce ai problemi reali del paese: il costo della vita, l’incertezza del lavoro, la corruzione, la repressione, la violenza, la condizione della donna e l’ipocrisia religiosa. Le sue paure sono quotidiane e concrete. E l’insistente preoccupazione per il prezzo del pane ci fa subito pensare alla più recente rivolta tunisina, del gennaio 2011, partita proprio da quella rivendicazione, e poi cresciuta ed estesasi agli altri paesi arabi. Anche la religiosità è messa a nudo. Una fede spesso più di facciata, rituale e meccanica, che non mossa da uno slancio spirituale sincero. I personaggi pregano, fanno le abluzioni, temono il giudizio divino, si rivolgono spesso a dio, ma poi rubano, tradiscono, mentono, sono corrotti o sfruttatori. Quella di Hassinu è la rivolta individuale di un personaggio ancora atipico, capace di confrontarsi con le contraddizioni di una società decadente che si maschera dietro a una morale conservatrice e a un potere repressivo. Ma ciononostante rimane un uomo impaurito che asseconda in certo modo il suo isolamento con prese di posizione sempre interiori, mai pubbliche. Solo nel dialogo con se stesso esprime liberamente le proprie critiche. Nel confronto con gli altri mantiene il profilo più remissivo che gli impongono il codice sociale e il controllo politico. Il registro è sempre colloquiale, ma in grado diverso secondo le diverse situazioni. Nei monologhi, che infrangono importanti tabù, il linguaggio è molto più sciolto, mentre nei dialoghi è più controllato e codificato, sottolineando l’autocensura e l’autorepressione dei personaggi. Come già negli altri due romanzi, anche in questo Lakhous dimostra una grande attenzione per la lingua parlata e una grande abilità nel riprodurla. L’originalità e la genuinità della sua scrittura stanno proprio in questo. Linda Zicca La luna fredda, Jeffrey Deaver, Sonzogno 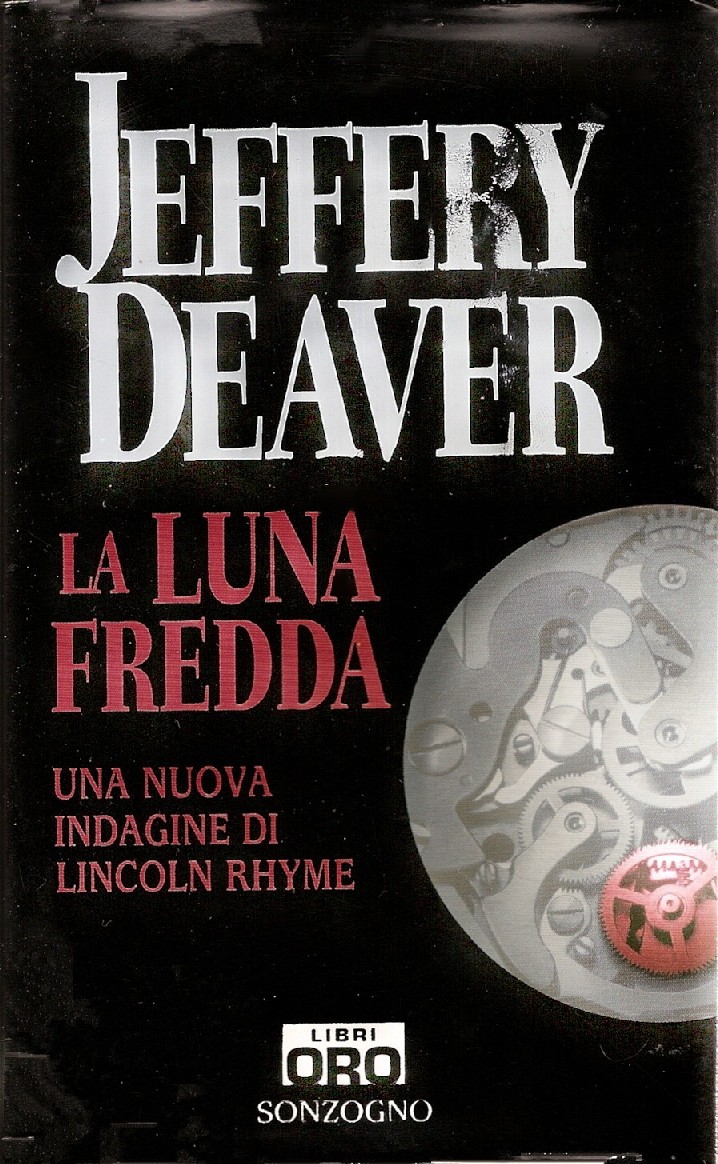 Quando vado in vacanza posso dimenticarmi lo spazzolino da denti o il dentifricio o lo shampoo. Non che io non tenga alla mia igiene personale. No. Semplicemente, sono cose che posso trovare ovunque: da Oslo a Kota Kinabalu. Quello di cui certamente non potrei fare a meno è una buona scorta di libri. Di solito cerco di alternare: un saggio, un classico, un noir, un autore italiano... E così via, cercando di conciliare la necessità di coprire l’intero periodo del viaggio con lo spazio necessariamente limitato in valigia (non per niente acquisto solo edizioni tascabili). Ciò nonostante, mi capita di fare male i conti e ritrovarmi a qualche giorno dal ritorno con le scorte esaurite. Allora tocca arrangiarsi e soprattutto accontentarsi. Recentemente mi è accaduto qualcosa del genere e tutto quello che son riuscito a trovare è stato, appunto, questo thriller del creatore di Lyncoln Rhyme. Autore non del tutto nuovo per me, avendo già letto a suo tempo diversi titoli con e senza il criminologo tetraplegico. Ebbene, c’è una cosa che mi sento di dire (come si dice in questi casi? assumendomene tutta la responsabilità): Jeffrey Deaver è un cialtrone. Andiamo, una regola fissa del noir è che nulla, men che meno il colpevole, deve essere come sembra. Ma Jeffery va oltre: nei sui romanzi (e qui si supera) l’immancabile serial killer è uno che finge di essere qualcuno che finge di esser un altro. Qui addirittura si inventa una complicatissima serie di delitti/non delitti commessi al solo di scopo di… fingere di raggiungere un determinato fine per ottenerne in realtà un terzo. Un piano che nella realtà avrebbe meno di zero possibilità di essere concepito prima ancora che realizzato. Lo so, in letteratura il verosimile non è un obbligo, anzi, a volte è persino sconsigliabile. Peccato che per tutte 464 pagine il nostro autore ci somministri dosi massicce di dettagli, in quella che risulta una stucchevole e virile gara a chi ce l’ha più lungo tra il misterioso vero/finto/verissimo assassino e l’insopportabilmente antipatico criminalista. Si crede furbo, Deaver, e crede di fregarci alternando dialoghi mai convincenti a narrazione onnisciente per mostrarci o nasconderci quello che di volta in volta gli fa comodo. Insomma alla fine, in questo volume più che in molti altri, Deaver sfoggia tutti i suoi limiti di narratore e la sua furbizia di produttore seriale di best seller. Spiace francamente leggere in quarta di copertina il virgolettato di Faletti, che dice di invidiare il talento di Deaver. In un attimo si è dissolta la timida curiosità che avevo di leggere qualcosa dello scrittore milanese. Giulio Crotti E al cinema.... Quella che apparentemente potrebbe sembrare la storia della nascita di Facebook, IL fenomerno di questo inizio di millennio per la gioventù cresciuta a pane e computer, è in realtà un ritratto piuttosto fedele ed impietoso di una generazione vuota e delusa dall’eredità di quella precedente, incapace ma soprattutto disinteressata a comprenderne linguaggio ed aspirazioni: una generazione divisa tra giovani ricchi che pensano tutto gli sia dovuto per diritto di nascita e giovani talenti che cercano di riempire il vuoto emotivo e di ideali con inutili ricchezze, acquisite troppo velocemente e con troppa facilità. La parabola umana verosimile ma non vera di Mark Zuckerberg, creatore di uno dei fenomeni mondiali di massa che più hanno modificato non solo il modo di vivere Internet ma la realtà stessa, The Social Network non cerca infatti la fedeltà dei fatti: prende piuttosto un personaggio complesso e controverso come Zuckerberg, ottimamente interpretato dalla giovane promessa Jesse Eisenberg, e lo trasforma in un paradigma vivente di una generazione allo sbando, sommersa dalle informazioni ma incapace di gestirle emotivamente, una gioventù impaurita ed arrogante allo stesso tempo, che cerca di mascherare la propria vulnerabilità con un cinismo di facciata. Lo sceneggiatore Sorkin sceglie di sviluppare il racconto su tre distinte linee narrative che si intrecciano tra loro , con particolare attenzione all’evoluzione del rapporto tra i suoi fondatori, che erano due amici al college di Harvard, ovvero Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg, rispettivamente il finanziatore iniziale e la geniale mente dietro a tutta l’impresa. Curiosamente, la storia si sviluppa in maniera molto simile a quello che succederebbe in una storia romantica tra un uomo e una donna, infatti c’è l’iniziale entusiasmo e la speranza di un futuro insieme, poi sorgono le prime incomprensioni e le prime liti, la “relazione extra-coniugale”, rappresentata in questo caso dall’amicizia tra Zuckerberg e Sean Parker, fondatore di Napster, e per finire la definitiva rottura, fatta di avvocati, di processi, di ripicche infantili, con un finale permeato da un senso generale di sconfitta di entrambe le parti che lascia l’amaro in bocca allo spettatore. Sul personaggio principale resta un alone di mistero, e l’intera vicenda è racchiusa tra i due giudizi estremamente contrastanti espressi su di lui rispettivamente nel prologo dall’ex-ragazza e nell’epilogo da un assistente dello studio legale che lo rappresenta, non a caso giudizi dati da donne in una vicenda esclusivamente al maschile, e che rappresentano le due opinioni tra cui si trova ad oscillare anche lo spettatore all’uscita dalla sala. Impossibile non citare, come elemento essenziale per la riuscita del film, il magnifico lavoro fatto con la colonna sonora da Trent Reznor e Atticus Ross, componenti del gruppo Nine Inch Nails, una partitura capace di imprimere ritmo e tono alla narrazione, in modo da diventare un tutt’uno con le immagini di Fincher e il testo di Sorkin: basta vedere il folgorante incipit, e tutta la musica che accompagna la sequenza alternata tra la stanza di Zuckerberg mentre mette in atto la sua vendetta informatica contro la ragazza che l’ha appena scaricato e il festino orgiastico che contemporaneamente sta avendo luogo in uno dei più esclusivi circoli di Harvard. Quella che apparentemente potrebbe sembrare la storia della nascita di Facebook, IL fenomerno di questo inizio di millennio per la gioventù cresciuta a pane e computer, è in realtà un ritratto piuttosto fedele ed impietoso di una generazione vuota e delusa dall’eredità di quella precedente, incapace ma soprattutto disinteressata a comprenderne linguaggio ed aspirazioni: una generazione divisa tra giovani ricchi che pensano tutto gli sia dovuto per diritto di nascita e giovani talenti che cercano di riempire il vuoto emotivo e di ideali con inutili ricchezze, acquisite troppo velocemente e con troppa facilità. La parabola umana verosimile ma non vera di Mark Zuckerberg, creatore di uno dei fenomeni mondiali di massa che più hanno modificato non solo il modo di vivere Internet ma la realtà stessa, The Social Network non cerca infatti la fedeltà dei fatti: prende piuttosto un personaggio complesso e controverso come Zuckerberg, ottimamente interpretato dalla giovane promessa Jesse Eisenberg, e lo trasforma in un paradigma vivente di una generazione allo sbando, sommersa dalle informazioni ma incapace di gestirle emotivamente, una gioventù impaurita ed arrogante allo stesso tempo, che cerca di mascherare la propria vulnerabilità con un cinismo di facciata. Lo sceneggiatore Sorkin sceglie di sviluppare il racconto su tre distinte linee narrative che si intrecciano tra loro , con particolare attenzione all’evoluzione del rapporto tra i suoi fondatori, che erano due amici al college di Harvard, ovvero Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg, rispettivamente il finanziatore iniziale e la geniale mente dietro a tutta l’impresa. Curiosamente, la storia si sviluppa in maniera molto simile a quello che succederebbe in una storia romantica tra un uomo e una donna, infatti c’è l’iniziale entusiasmo e la speranza di un futuro insieme, poi sorgono le prime incomprensioni e le prime liti, la “relazione extra-coniugale”, rappresentata in questo caso dall’amicizia tra Zuckerberg e Sean Parker, fondatore di Napster, e per finire la definitiva rottura, fatta di avvocati, di processi, di ripicche infantili, con un finale permeato da un senso generale di sconfitta di entrambe le parti che lascia l’amaro in bocca allo spettatore. Sul personaggio principale resta un alone di mistero, e l’intera vicenda è racchiusa tra i due giudizi estremamente contrastanti espressi su di lui rispettivamente nel prologo dall’ex-ragazza e nell’epilogo da un assistente dello studio legale che lo rappresenta, non a caso giudizi dati da donne in una vicenda esclusivamente al maschile, e che rappresentano le due opinioni tra cui si trova ad oscillare anche lo spettatore all’uscita dalla sala. Impossibile non citare, come elemento essenziale per la riuscita del film, il magnifico lavoro fatto con la colonna sonora da Trent Reznor e Atticus Ross, componenti del gruppo Nine Inch Nails, una partitura capace di imprimere ritmo e tono alla narrazione, in modo da diventare un tutt’uno con le immagini di Fincher e il testo di Sorkin: basta vedere il folgorante incipit, e tutta la musica che accompagna la sequenza alternata tra la stanza di Zuckerberg mentre mette in atto la sua vendetta informatica contro la ragazza che l’ha appena scaricato e il festino orgiastico che contemporaneamente sta avendo luogo in uno dei più esclusivi circoli di Harvard. F |
|
 | ||


 The Social Network è sembra ombra di dubbio il culmine di due carriere, quella dello sceneggiatore e commediografo Aaron Sorkin (Codice D’Onore, La Guerra di Charlie Wilson), e quella del regista David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac), in quanto rappresenta una perfetta sintesi del lavoro di entrambi, in cui il talento visivo e la capacità di raccontare per immagini dell’uno, si fonde alla perfezione coi dialoghi intelligenti, ironici e provocatori dell’altro.
The Social Network è sembra ombra di dubbio il culmine di due carriere, quella dello sceneggiatore e commediografo Aaron Sorkin (Codice D’Onore, La Guerra di Charlie Wilson), e quella del regista David Fincher (Seven, Fight Club, Zodiac), in quanto rappresenta una perfetta sintesi del lavoro di entrambi, in cui il talento visivo e la capacità di raccontare per immagini dell’uno, si fonde alla perfezione coi dialoghi intelligenti, ironici e provocatori dell’altro.